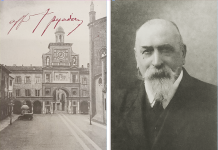Di seguito la seconda e ultima parte.
La notte più buia – parte 2
Vittoria stava sognando e si era risvegliata per terra. Sulla schiena la rete del letto, un lembo di lenzuolo sulla faccia. L’aveva scostato con la mano destra. L’altra, non riusciva a muoverla. Non poteva essere vero. Avrebbe voluto spalancare gli occhi, forse stava ancora sognando, ma per quanto si sforzasse non riusciva a vedere oltre il buio in cui era sprofondata. Aveva dolore forte, alla spalla. Non sentiva più una gamba. Aveva allungato il braccio in cerca della sponda del lettino, del cuscino e dei riccioli di Giuseppe. Era lì, accanto a lei… Dov’era finito? Dove sei Giuseppe, vita mia? Il suo bambino…
Aveva tutto il lato sinistro bloccato. La gamba, schiacciata, non le rispondeva. Ah, poterla staccare dal corpo e arrivare da Giuseppe, afferrarlo, stringerlo al cuore! Fuggire. Era un incubo, un brutto sogno. Appena desta sarebbe svanito. Sì, sarebbe svanito…
«Giusè! Giuseppe!» aveva tentato di urlare. La polvere le soffocava le parole in gola.
Voleva svegliarlo, dirgli di alzarsi e uscire, correre, chiedere aiuto. Ma il pensiero non riusciva a tramutarsi in suono. Era un mugolio senza senso. Giuseppe non avrebbe capito.
Aveva sentito la voce di Antonio che la chiamava. Con tutte le sue forze aveva urlato: «Antò… Giuseppe, dov’è?».
Il bambino… Il suo bambino. Il suo amore grande. Ora se ne accorgeva quanto grande.
Non poteva muoversi, non poteva fare nulla per sé, per lui. Nulla di ciò che invece avrebbe dovuto. Sempre così: la sua incapacità, la costante di tutta la sua vita… Era scoppiata in pianto. Perché proprio adesso, perché proprio a lei.
«Non voglio morire. Non ora. Non così….».
Mentre Caterina correva verso casa, un boato aveva squarciato il silenzio; le era mancata la terra sotto i piedi, era caduta, aveva provato ad alzarsi, era caduta ancora, si era aggrappata a un lastrone di basalto che si apriva sotto di lei, si era rialzata, terrorizzata aveva ripreso la corsa inciampando, cadendo, risollevandosi, cadendo ancora.
Intorno a lei miseri castelli di carta venivano giù. Il paese si sbriciolava; il paese, il suo paese, sprofondava. Un pozzo nero senza fine.
Aveva perso l’orientamento e girava attorno a sé, atterrita. Riconosciuta un’insegna penzolante, si era diretta in quella direzione. La strada di casa.
Aveva gettato un urlo. L’intravedeva, nella notte senza luce, ed era un dolore indicibile. Il cancello era storto, spalancato. Una parete non c’era più; l’altra resisteva, sghemba, con le imposte divelte e squarci minacciosi sul chiaro intonaco del prospetto.
Era franata in ginocchio, la faccia a terra, le mani sulla testa, stremata, disperata, fradicia, insanguinata, singhiozzante.
I cani le erano corsi incontro, guaivano, la leccavano, la spronavano ad alzarsi spingendola col muso. Si era rialzata, era entrata da quella che era stata una porta finestra. I vetri disseminati per terra. Funcia e Nerino la seguivano.
«Mamma! Papà!» Piangeva e urlava, sconfortata; inciampava e proseguiva.
«Cate!».
«Antonio! Sei qui…» mormorava e piangeva. «Il papà… la mamma…».
L’aveva raggiunto e stretto forte. Tremava.
Antonio l’aveva accolta sotto la coperta.
«Dobbiamo girare dal retro! Da dentro non si riesce a passare».
Erano usciti sorreggendosi a vicenda. Si erano appoggiati alla parete esterna e procedevano cauti: costeggiando il muro laterale avrebbero raggiunto l’angolo che conduceva al retro della casa, al davanzale della finestra – con i vasi di ciclamino – e subito dopo all’accesso in cucina. Antonio davanti, tastava il muro e rincuorava la sorella, la incitava a farsi coraggio, resistere, avere fiducia; Caterina lo seguiva, sempre più incerta sulle gambe. La pioggia lavava loro di dosso sangue e terra. Avanzavano, gli occhi sbarrati in cerca di spiragli nell’abisso del buio. I cani li avevano preceduti. Svoltato l’angolo, fatti pochi passi, la parete s’interrompeva. L’ala vecchia della casa non aveva retto al brivido della terra.
Antonio si era bloccato, non aveva più parole.
Si era girato verso la sorella. Caterina aveva capito.
Era svenuta tra le sue braccia.
L’alone grigio del primo mattino era planato su quello che restava del paese. In una manciata di secondi il terremoto aveva rovesciato case, masserie, stalle, chiese e botteghe. Abbattuto alberi e piantagioni, palazzi e castelli. Risucchiato nelle proprie viscere strade e trazzere, spostato argini e colline. Vomitato acqua e fango. Dilaniato uomini e animali, spazzato sogni, speranze, abitudini di una vita. Cancellato identità secolari.
Quel luogo, la terra del Belìce, Dio sembrava esserselo scordato.
Poi erano caduti i primi fiocchi. La coltre bianca ricopriva corpi e macerie. Inzuppava la gente che vagava in cerca di qualcosa, di qualcuno. Di riparo. Le bestie che cercavano le loro stalle, il padrone. Non c’erano più i tetti delle case di tufo, la strada, il vicolo, la piazza, il cortile, da rivestire di sogno. Solo rovine e disperazione.
Antonio e Caterina, dopo avere cercato invano di farsi largo tra le macerie, essersi sgolati a chiamare i loro cari, a uno a uno, avere pianto – impotenti – graffiandosi le mani nel tentativo di scavare e spostare pietre e tegole, si erano rannicchiati nell’orto, con addosso freddo e sconforto.
Il rumore degli elicotteri li aveva scossi dal torpore. Si erano incamminati verso il paese; lo spettacolo era insostenibile, tremendo, desolante. Tetti crollati, fili elettrici divelti e grondaie ciondolanti come impiccati. Uomini e animali in cerca di acqua e di cibo. Dov’è il campanile della Matrice? Lì c’era il municipio, lì la caserma dei carabinieri…
Ovunque solo distruzione, polvere e fango.
Erano tornati sui propri passi, dagli affetti che erano lì, a qualche parte, sotto ciò che era rimasto della loro casa. Avevano spostato vetri, pezzi d’intonaco, pietre, calcinacci e mattoni. Avevano scavato alla luce del giorno. Uomini sconosciuti, con pale e picconi, erano accorsi in loro aiuto.
Dinanzi a quello che era stato il camino, i brandelli di una lettera. Più oltre i quadri a punto croce della mamma, strappati, zuppi di pioggia e impolverati. Ormai stracci vecchi.
I cani – su quello che era stato il vano della porta – sorvegliavano vigili, come avevano sempre fatto.
Leggi anche La notte più buia – Parte 1